Ministro o ministra, prefetto o prefetta? Declinare i nomi al femminile è solo una questione di forma?
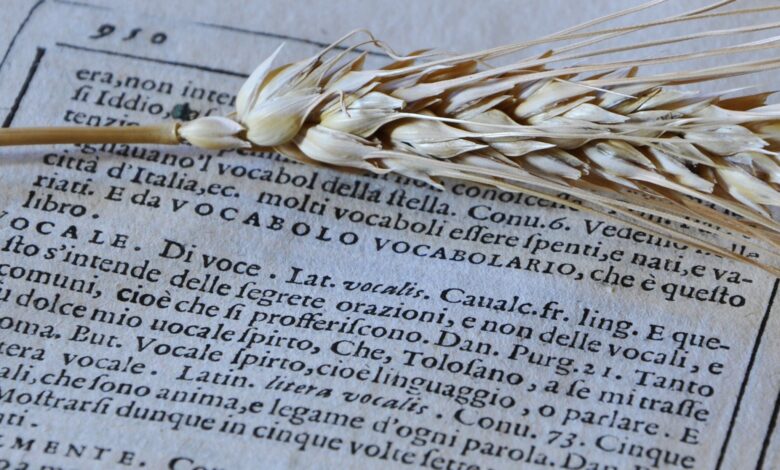
In questi ultimi anni una questione squisitamente linguistica sta tenendo acceso il dibattito sui social: quella relativa alla declinazione di alcuni nomi al femminile.
Si deve dire Ministro o Ministra, quando questo ruolo è ricoperto da una donna? Direttore o Direttrice? Prefetto o Prefetta?
“Ormai ministra – come sostiene l’Accademia della Crusca – è assolutamente passato nella lingua, viene scritto e funziona”. La resistenza verso queste forme femminili è di pregiudizio, non linguistica. “La lingua ha gli strumenti per fare questo passaggio: esiste maestro/maestra, non si vede perché non debba esserci ministro/ministra”.
La querelle comunque non è certo nuova, come ha giustamente affermato Claudio Marazzini, che è stato presidente dell’Accademia della Crusca fino al 2023; sulle pagine di “Famiglia Cristiana” ha ricordato che già nel 1986, al tempo del governo Craxi, erano state pubblicate le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”.
I toni del dibattito si erano in seguito riaccesi quando Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica, riferendosi all’allora Presidente della Camera, Laura Boldrini, aveva dichiaratamente espresso la sua opinione affermando di preferire nettamente le forme declinate al maschile, nel caso in cui una determinata carica venisse ricoperta da una donna. Dopo Napolitano era intervenuto anche Vittorio Sgarbi con la sua consueta “foga verbale” (“Basta parole al femminile, sei una zucca vuota”, aveva dichiarato riferendosi alla Boldrini. E zucca è sicuramente un termine declinato al femminile!). Nel dibattito era intervenuta anche l’ex Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, la quale aveva invece affermato di voler essere chiamata Ministra e non Ministro.
Lo stesso Marazzini aveva allora sollecitato un pacato dibatto presso l’Accademia, tra esperti ed esponenti del mondo politico interessati alla questione, quali la Boldrini, la Boschi, il Presidente emerito Napolitano e la Direttrice generale delle pari opportunità dott.ssa Boda.
Queste furono le conclusioni a cui si giunse:
“La tolleranza che usiamo nei confronti di molte oscillazioni nell’uso della lingua deve essere applicata anche qui… Naturalmente ci sono casi in cui la scelta si è ormai orientata in maniera ormai chiara. “Sindaca” e “ministra” appartengono ormai al linguaggio comune. Dico di più: la lingua è una democrazia, in cui la maggioranza governa, i grammatici prendono atto delle innovazioni e cercano di farle andare d’accordo con la tradizione, e le minoranze, anche ribelli, hanno pur diritto di esistere, senza dover temere la gogna mediatica. Dunque mi pare giusto accordare il diritto di scrivere e di parlare anche al passatista… che non ha fatto neppure il primo passo, che non è nemmeno arrivato ad accettare “la sindaca”. Naturalmente sarà bene cercare di convincerlo ad adattare le proprie scelte al mutamento della società, ma dovrà essere una lezione di razionalità, non un anatema… Invocare la grammatica per condannare “il sindaco” usato per una donna, o viceversa per condannare “la sindaca”, a sua volta usato per una donna, non ha senso. L’una o l’altra condanna derivano o da radicalizzazione ideologica, o da affezione alla tradizione linguistica… Va precisato tuttavia che i giudizi sul “bello” o “brutto” di questa o quella forma linguistica, spesso evocati per giustificare una determinata scelta, sono soggettivi e scientificamente nulli.
I nomi femminili ministra, sindaca non dipendono dalla grammatica, che accetta sia il maschile tradizionale sia il femminile innovativo, ma da una battaglia ideologica trasportata nella lingua dalle donne (o da alcune di esse) quando conquistano nuovi spazi in politica e nel mondo del lavoro;
le forme che escono in -e, come assessore, presidente, dovrebbero essere investite meno di altre dallo sforzo di chi vuole innovare in funzione del genere: basta insomma l’articolo, senza tirare in ballo la morfologia suffissale, perché in italiano abbiamo già “il prete”, “l’abate”, e “la forbice”, “la neve”, “la specie”, tutti con uscita in -e.”
Spesso però le nuove parole a tanti sembrano avere un suono sgradevole o cacofonico. Ma ciò succede perché non siamo abituati a sentirle spesso. “All’inizio del Novecento i linguisti annotavano liste di parole obbrobriose, che noi usiamo”.
D’altronde l’italiano è una lingua viva, che cambia con il tempo e che rispecchia anche il mutare della società.
Come non ricordare con tenerezza la maestra delle scuole elementari di Copparo, Margherita Aurora, che inviò la parola “petaloso”, inventata dal suo piccolo alunno Matteo, all’Accademia della Crusca perché venisse valutata.
Questa fu la risposta che gli illustri membri dell’Accademia diedero alla maestra e al piccolo Matteo: “Una parola entra nel vocabolario se tante persone la usano e la capiscono…Non sono gli studiosi a decidere quali parole nuove sono belle o brutte, utili o inutili. Quando una parola nuova è sulla bocca di tutti (o di tanti) allora lo studioso capisce che quella parola è diventata una parola come le altre e la mette nel vocabolario”.
L’ex Presidente dell’Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio, per evitare alcuni possibili equivoci nelle sintesi che si vanno diffondendo in rete, “tiene a ribadire l’opportunità di usare il genere grammaticale femminile per indicare ruoli istituzionali (la ministra, la presidente, l’assessora, la senatrice, la deputata ecc.) e professioni alle quali l’accesso è normale per le donne solo da qualche decennio (chirurga, avvocata o avvocatessa, architetta, magistrata ecc.) così come del resto è avvenuto per mestieri e professioni tradizionali (infermiera, maestra, operaia, attrice, etc.)”.
Risulta abbastanza evidente che il dibattitto sul linguaggio di genere è piuttosto recente ed è strettamente legato al fatto che le donne hanno cominciato da poco ad assumere incarichi di responsabilità.
Nella storia dell’età moderna, infatti, raramente le donne hanno ricoperto ruoli di potere in modo diretto. Se si eccettuano i casi di alcune importanti regine (si pensi, solo per citarne alcune, ad Isabella di Castiglia o a Elisabetta I Tudor) arrivate al trono a causa di complicate vicende dinastiche, le donne se volevano esercitare il potere dovevano farlo per via indiretta, influenzando con la loro grazia e il loro fascino le decisioni degli uomini che avevano accanto. Nel celebre saggio “Amanti e regine. Il potere delle donne” (2005), la saggista e storica Benedetta Craveri ha efficacemente mostrato le vie, spesso tortuose, attraverso le quali le donne riuscirono a imporsi con le loro idee sul panorama politico europeo, influenzando le decisioni dei sovrani di cui erano le favorite.
Per esercitare il potere dunque le donne dovevano mettere in mostra le loro qualità più squisitamente femminili. Pensiamo ad esempio a Jeanne Antoinette Poisson, marchesa di Pompadour, che riuscì a diventare la più importante concubina e consigliera di re Luigi XV ed un’icona di stile anche per i secoli a venire. Tuttavia anche nel caso di Jeanne-Antoinette il soprannome che le venne dato, “Reinette”, è piuttosto illuminante: spiega da solo il suo ruolo alla corte di Versailles. Ancora una volta, dunque, emerge con chiarezza come il termine utilizzato per definire una persona o una situazione non sia mai da considerare una questione di poco conto.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine dei regimi nazi-fascisti in Europa, la presenza femminile nei posti di comando ha cominciato gradualmente a farsi sentire.
Oggi, trascorsi ormai molti anni, non mancano certo figure femminili di spicco nel panorama politico europeo. In Italia dal 22 ottobre 2022, abbiamo per la prima volta una premier donna: Giorgia Meloni.
Ma le difficoltà che le donne incontrano ogni giorno per raggiungere e gestire un potere che è nato e si è calibrato su esigenze esclusivamente maschili spiegano in parte il fatto che molte di loro scelgano di farsi chiamare con il proprio titolo declinato al maschile, come se questo conferisse di per sé più prestigio e rispetto; per non parlare dell’appellativo “signora” spesso e volentieri usato anche sul luogo di lavoro al posto del titolo di studio conseguito (cosa che invece non succede mai agli uomini);
Certo ci sono delle eccezioni: basti pensare alla dott.ssa Maria Carmela Librizzi che preferisce farsi chiamare “la prefetta” e non il prefetto. La Librizzi, recentemente intervistata, ha raccontato come le sia capitato durante importanti trattative di essere chiamata signora e di essere stata costretta a ribadire di essere “prefetta” sul luogo di lavoro e signora al di fuori.
Tornando al discorso della disparità uomo-donna, mentre nell’ambito del Ministero dell’Interno lavorano tante donne e molte sono le prefette, l’approccio con l’esterno, invece, costituisce uno spartiacque. La prefetta Librizzi ricorda che, essendo vincitrice di concorso, era stata assegnata alla Prefettura di Ragusa e sistemata in una stanza assieme a un segretario-ragioniere; quando il pubblico entrava nella stanza si rivolgeva al segretario chiamandolo dottore mentre chiamava lei signorina. Purtroppo retaggi culturali e di genere fanno sì che per molti la donna possa essere solo la segretaria. “Ripeto – continua la prefetta – la qualifica di genere non mi interessa ma quando la gentilezza, il modo di porgersi non arrogante vengono scambiate per debolezza”, allora sfato tutto questo subito e “faccio rispettare il ruolo non la mia persona”: l’approccio non è conflittuale ma ognuno deve rispettare il suo ruolo.
“Se sono prefetta – continua la Librizzi – lo devo a Rosanna Oliva che si è presentata al concorso per prefetto non perché le interessasse il ruolo in quanto tale, ma perché voleva affermare un principio di uguaglianza senza distinzione di sesso” (fino al 1960 alle donne erano proibite le carriere pubbliche, come quella in magistratura, e solo nel 1998 le donne vengono ammesse alle carriere militari e il riconoscimento della legge è avvenuto dopo anni di battaglie).
La questione linguistica non può quindi essere considerata una mera questione formale come sostengono alcune donne e intellettuali che vorrebbero dare più peso al ruolo ricoperto e alla funzione che al titolo. La forma linguistica non può essere separata dal contenuto e come ha affermato anche Hegel, nella sua “Scienza della logica”, la grammatica è simile ad “un’impalcatura” che nasce sempre dalle categorie del reale. Quindi se davvero vogliamo raggiungere la parità ed accettare che le donne possano ricoprire ogni ruolo, anche la lingua e le sue declinazioni devono cambiare ed adeguarsi a questa mutata realtà sociale.




