Dove inizia e finisce l’infinito? I confini della conoscenza
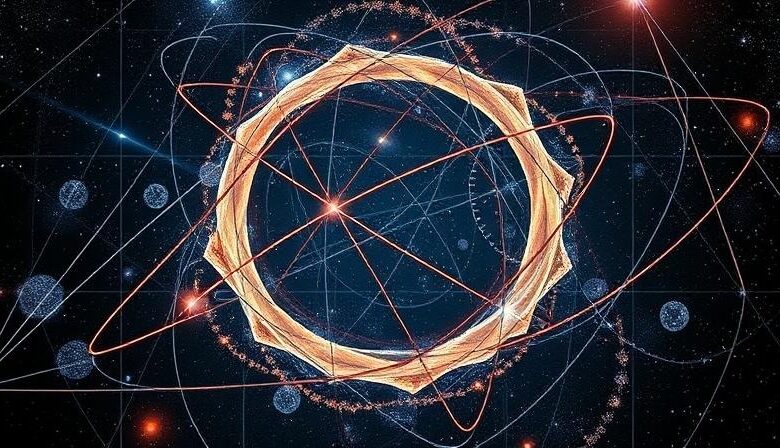
Ci sono concetti che sfidano la nostra capacità di comprensione e i nostri limiti intellettuali, ma che ci attraggono in maniera irresistibile: l’infinito è uno di questi. È una definizione che applichiamo alla vastità dell’universo, e ritroviamo nei fondamenti della matematica e nelle speculazioni filosofiche che da secoli tentano di definirlo. Se il finito è il dominio del misurabile, l’infinito rappresenta ciò che sfugge alla nostra capacità di delimitazione, un orizzonte che si allontana ogni volta che proviamo a raggiungerlo. Aristotele, nella sua “Fisica”, distingue tra infinito potenziale e infinito attuale. L’infinito potenziale, per il filosofo greco, non può esistere come un’entità completa, ma come un processo senza fine, come la possibilità di dividere un segmento all’infinito senza mai esaurirlo. L’infinito attuale, invece, sarebbe un insieme infinito completamente realizzato, una nozione che Aristotele respingeva come impossibile nel mondo fisico. Tuttavia, la matematica moderna ha ripreso e ampliato queste distinzioni, con il lavoro di Georg Cantor, sul concetto di diversi livelli di infinito, come l’infinito “numerabile” dei numeri interi e l’infinito “non numerabile” dei numeri reali. Ma l’universo stesso è infinito? Per comprenderlo, possiamo osservare la radiazione cosmica di fondo, l’eco fossile del Big Bang che permea l’universo. Le misurazioni di questa radiazione, in particolare quelle ottenute dalla missione Planck dell’ESA, indicano che l’universo, su larga scala, appare estremamente piatto. Questo significa che la curvatura dello spaziotempo è talmente piccola da essere indistinguibile da zero, suggerendo che l’universo sia infinitamente esteso o, se finito, incredibilmente grande. Se fosse significativamente curvato, la radiazione cosmica di fondo mostrerebbe variazioni nei suoi pattern, indicando una geometria chiusa o aperta. Tuttavia, le osservazioni rivelano un universo che si conforma sorprendentemente bene alla geometria euclidea, lasciando aperta la possibilità che sia infinito.
Anche il tempo introduce paradossi simili. Sant’Agostino, nelle “Confessioni”, rifletteva sulla natura del tempo, affermando: “Se nessuno me lo chiede, so cos’è; ma se devo spiegarlo, non lo so più.” Questo riflette la nostra difficoltà nel definire il tempo senza ricorrere al concetto stesso di temporalità. La teoria della relatività di Einstein ha trasformato la nostra comprensione del tempo, dimostrando che esso non è assoluto, ma interconnesso con lo spazio in un continuum quadridimensionale. Il tempo può dilatarsi o contrarsi a seconda della velocità e della gravità, un effetto osservato nei satelliti GPS, che devono correggere costantemente il tempo misurato a bordo per evitare errori nella localizzazione terrestre. Nei buchi neri, la deformazione gravitazionale è così estrema che il tempo stesso sembra fermarsi per un osservatore esterno, portando a domande fondamentali sulla natura del tempo e della causalità.
Nel regno della meccanica quantistica, l’infinito assume una forma ancora più misteriosa. Il principio di sovrapposizione implica che una particella possa esistere in più stati contemporaneamente fino a quando non viene misurata. Inoltre, il concetto di vuoto quantistico mostra che il vuoto non è uno spazio statico e privo di eventi, ma un brulicare continuo di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, creando una sorta di infinito dinamico. Alcuni fisici, come Andrei Linde, hanno proposto che il nostro universo sia solo una bolla in un multiverso più grande, in cui nuove regioni dello spazio continuano a formarsi attraverso un’eterna inflazione.
Le scoperte più recenti suggeriscono che lo spazio-tempo stesso potrebbe non essere fondamentale, ma emergere da strutture più profonde. Il principio olografico, formulato da Juan Maldacena, ipotizza che l’universo tridimensionale possa essere una proiezione di informazioni codificate su una superficie bidimensionale ai suoi confini, una prospettiva che trova riscontro nella teoria delle stringhe e nella gravità quantistica. Parallelamente, la gravità quantistica a loop suggerisce che lo spaziotempo sia quantizzato in unità discrete, eliminando la necessità di una continuità infinita e offrendo nuove prospettive sulla natura della realtà.
Ma l’infinito è eterno? O si tratta di un’illusione umana? Jim Holt distingue tra infinito ed eterno: un universo infinito potrebbe aver avuto un inizio e, teoricamente, una fine, mentre l’eternità implica l’assenza stessa di un inizio o di una fine. Questo introduce un paradosso: può qualcosa esistere al di fuori del tempo? Se il tempo stesso fosse un fenomeno emergente, come suggeriscono alcune interpretazioni della gravità quantistica, allora il concetto di eterno potrebbe non avere senso nella nostra attuale comprensione della realtà.
L’infinito non è solo un’astrazione matematica o filosofica, ma una sfida alla nostra comprensione della natura stessa dell’esistenza. Ogni nuova scoperta in cosmologia e fisica quantistica apre più domande di quante ne risolva. Come scrisse David Hilbert: “Nessuno ci scaccerà dal paradiso che Cantor ha creato per noi.” Così, mentre esploriamo il cosmo e le leggi della natura, continuiamo a confrontarci con il mistero dell’infinito, consapevoli che la nostra ricerca potrebbe anch’essa non avere mai fine.




