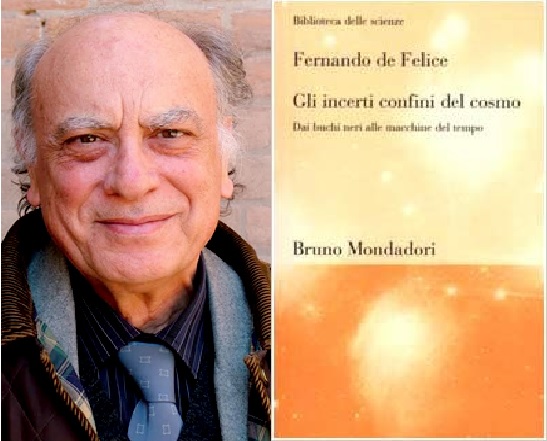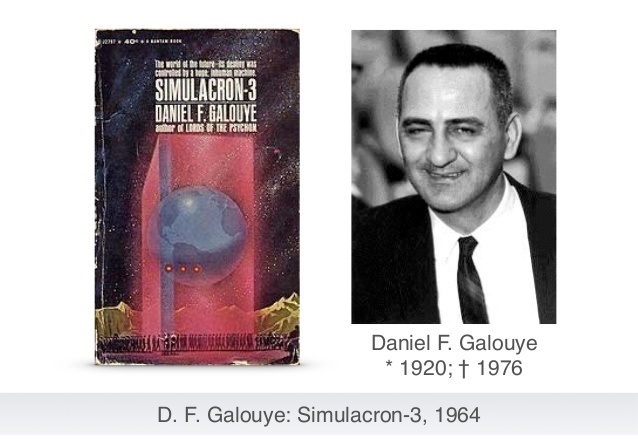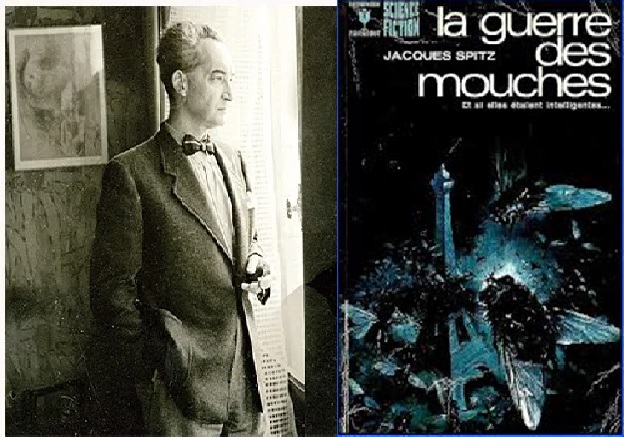Il “Samurai Solitario” di William Scott Wilson

Accennare un commento su quest’opera è, in effetti, una scusa per poter parlare di Miyamoto Musashi. Non che sia un libro mediocre o pessimo, tutt’altro, l’autore è stato assai scrupoloso, nel suo intento di stilare una biografia quanto più completa di Musashi ha ricercato e approfondito le innumerevoli fonti, andando spesso nei luoghi dove egli visse e scavando quando più a fondo possibile nell’incredibile quantità di detti, leggende e antiche testimonianze che sono fioriti intorno alle sue gesta. Il libro è una appassionata e rigorosa ricostruzione della personalità, delle gesta, della filosofia di quello che è considerato il più grande samurai (anche se il termine esatto dovrebbe essere “shugyosha”: che indica quei guerrieri erranti che non si sottomettevano all’autorità di un signore feudale) della storia del Giappone. Forse l’unico appunto che mi sento di muovere è relativamente all’indugiare dell’autore sulla nomenclatura giapponese, affastellando in alcuni momenti nomi su nomi (di personaggi, dei loro pseudonimi, delle scuole , dei luoghi, ecc.) cosa che crea, secondo me, una certa confusione e un vago senso di smarrimento a chi non è avvezzo con quell’idioma.
Musashi, “Il Samurai Solitario”, è, quindi, il personaggio di questo libro. Egli è sempre stato, da quanto anni fa ne sentii parlare, uno dei modelli principali a cui ho sempre tentato di ispirarmi.
La sua epopea inizia a 13 anni quando, da semplice monello di strada, sfida (quasi fosse un gioco) e sconfigge, con un bastone e a mani nude, Arima Hikei, spadaccino della scuola shinto-ryu. Da quel momento in poi la sua fama si accresce a dismisura, duello dopo duello con i più grandi samurai del tempo, dove ne esce sempre vincitore. Tutto questo fino all’età di trent’anni (in cui aveva già affrontato vittoriosamente più di 60 scontri), dopodiché, approfondendo le tematiche del buddismo zen, continuò sì ad accettare le sfide che la sua fama gli conduceva, ma limitandosi a dominare totalmente i vari avversari senza dar loro modo di poterlo attaccare e senza arrecare loro alcun danno, ma rendendoli consci, assieme agli astanti, della sua incredibile ed indiscutibile superiorità.
Nato come Bennosuke, nel 1584 nel villaggio di Miyamoto, morì a Higo il 19 maggio del 1645, all’età di 61 anni. Crescendo cominciò ad essere in disaccordo con il padre, tant’è che fu affidato ad uno zio paterno, il monaco Dorimbo. A 13 anni ebbe il suo primo duello, a 16 anni combatté nella battaglia di Sekigahara (una delle battaglie più importanti nella storia del Giappone, in cui si confrontarono i Tokugawa ed il clan Toyotomi, con la completa disfatta di quest’ultimi e la salita al potere dello shogunato dei Tokugawa: Miyamoto era schierato con i perdenti e, assieme a tutti gli altri sopravvissuti, dovette fuggire per salvarsi dalle sanguinose ritorsioni).
Le due sue imprese passate alla storia furono la distruzione della famosissima e storica scuola di schermidori del clan Yoshioka (fu sfidato, mentre si trovava a Kyoto, dai vari appartenenti al clan, sconfiggendoli tutti in singoli scontri, sino all’imboscata finale in cui uscì vincitore, con solo una freccia infissa sulla manica della giacca, contro l’ultimo rimasto che, per vendicare l’onore, aveva fatto nascondere, nel luogo della sfida, un nutrito gruppo di accoliti armati di archi e spade. Da allora in poi, venendo a mancare la famiglia di samurai che la gestiva, la scuola, antica e rinomata, fu chiusa per sempre e la sua arte si perse) e la sconfitta e uccisione del samurai Sasaki Kojiro.
Sullo scontro con Kojiro ci sono innumerevoli versioni e, anche, in epoca moderna, tante ricostruzioni filmiche. La vicenda, spogliata di ogni abbellimento, è essenzialmente questa: era stato organizzato un confronto, come era consuetudine a quell’epoca, tra Kojiro, famoso samurai detto anche “il Demone delle province occidentali” e lo sconosciuto Musashi, da tenere in un isolotto sito nel Giappone meridionale.
Kojiro era il classico esempio di samurai. Sempre impeccabile, ossequioso del lignaggio e delle tradizioni che si addicevano al suo rango, era alto, di bell’aspetto, vestiva in maniera ricercata e, aderendo alla concezione secondo la quale la spada era l’anima del samurai, possedeva una katana forgiata da un famoso maestro spadaio, più lunga del normale, considerata una vera e propria opera d’arte, che egli portava con fierezza sulla schiena sopra la sua casacca color cremisi e a cui aveva dato anche un nome: Monohoshi Zao. La sua tecnica nel maneggiarla, veloce e precisa, era impareggiabile e affascinava talmente chi vi assisteva che questi lo pregava subito di prenderlo come suo allievo.
Musashi, di contro, ancora all’epoca poco conosciuto, era un vero enigma. Non si curava molto dell’estetica nel vestire, ma ne considerava solamente l’aspetto funzionale, non vantava l’appartenenza a scuole di scherma rinomate o leggendarie, l’insegnamento di maestri celebri e nemmeno la discendenza da clan guerreschi prestigiosi. Era schivo e solitario.
Questo scontro fu un capolavoro di tattica da parte di Musashi. Egli giunse sull’isola, dove già lo aspettava un arrabbiato Kojiro, appositamente in ritardo, condotto da un barcaiolo. Invece di brandire la katana scelse un remo della barca e con questo affronto l’avversario: tutto questo faceva, in effetti, parte di una studiata e raffinata strategia nel fare perdere concentrazione e calma a Kojiro, per il quale la precisione e la puntualità erano inderogabili regole fra pari rango e il cui infrangerle si traduceva nel più riprovevole degli insulti e, peggio ancora, il presentarsi a lui armato di un remo era come dirgli di considerarlo meno che niente.
Cosicché un furibondo Kojiro si avventò su Musashi, con un fendente alla testa a cui quest’ultimo rispose quasi all’unisono con un devastante colpo di remo al viso. Kojiro stramazzò al suolo, dove fu finito con una percossa che gli sfondò il torace, mentre a Musashi gli cadde, recisa, la fascia con cui aveva cinto la fronte. Dopodiché egli si avviò tranquillamente alla barca per ritornare indietro.)
L’aspetto affascinante di quest’uomo non sono tanto le sue innumerevoli imprese, per altro assai notevoli, ma il suo comportamento in relazione a ciò che egli rappresentava. Basti dire che in quel periodo turbolento i samurai facevano di tutto per accrescere la loro fama di valenti spadaccini, in modo da poter essere accettati come combattenti da un clan potente e prestigioso: più godevano di considerazione e migliore era la collocazione a cui potevano ambire e da cui ne derivava protezione, agiatezza e più elevate condizioni di vita. Musashi invece faceva esattamente il contrario, man mano che la sua reputazione cresceva, molti signori gli chiedevano che entrasse al loro servizio, ma lui rifiutava sempre e, quanto non era consigliabile farlo, mandava in sua vece un allievo particolarmente abile oppure, in alcuni casi, i suoi figli adottivi: per lui la libertà era un bene supremo alla quale non avrebbe mai rinunciato. Egli viveva con poco, errabondando e passando molto tempo immerso nella natura. Come abbiamo detto vestiva sobriamente, non possedeva nulla tranne quello che gli era strettamente indispensabile, il suo vivere era improntata alla semplicità, anche nella sua arte guerresca non faceva sfoggio di moduli estremamente complicati, non vantava di conoscere “mosse segrete” da insegnare solamente agli adepti più fidati, non millantava la conoscenza di tecniche micidiali suggeritegli in particolari condizioni da dei, demoni o entità soprannaturali, non imbastiva complicati ed esoterici cerimoniali, con patti di sangue e giuramenti di segretezza (cose, tutte queste, a cui erano avvezzi abbandonarsi molti samurai), ma insegnava la sua arte tenendo conto del livello e delle capacità di ciascun allievo, mostrando la linearità e basilarità dei “colpi” da lui sviluppati e puntualizzando sempre che era spogliando le tecniche dai vari orpelli che si giungeva all’efficacia.
Quello su cui lui principalmente puntava e in cui credeva era l’uomo e non la tecnica o la spada. Infatti in molti dei suoi duelli (beninteso: con i più forti samurai!), come abbiamo poc’anzi visto, egli non usa neanche la katana che possedeva, ma un remo, un bastone o un ramo che egli intagliava a mò di spada di legno (nelle tecniche marziali di scherma giapponese, la spada di legno, detta “boken”, si utilizza essenzialmente per l’allenamento). Pe lui la tecnica e le armi sono solo mezzi, il fulcro importante di uno scontro (e di qualsiasi attività che sia o meno marziale) è l’uomo, il suo sapersi porsi, la sua capacità di dominare le situazioni.
Giusto per puntualizzare il suo approccio diretto e semplice nelle cose, si prenda ad esempio il manoscritto che egli scrisse all’età di 60 anni, quando già cominciava a presagire le avvisaglie della morte, noto come “Il Libro dei Cinque Anelli” (a tutt’oggi studiato nei corsi di management!), in cui, spiegando i principi e la filosofia su cui si basa la sua tecnica marziale, egli inizia dicendo: “… per scrivere questo libro non mi ispiro alla Legge del Buddha o agli insegnamenti di Confucio, né riprendo gli antichi libri di cavalleria e di tattica militare. Nella luce del sentiero del Cielo e di Kwannon, la notte del decimo giorno, del decimo mese, all’ora della Tigre, semplicemente prendo il pennello e incomincio a scrivere.”
Era un uomo assai colto, esperto nell’arte della “composizione dei giardini” (in merito a cui era molto richiesto), della “cerimonia del tè” e della pittura ad inchiostro monocromatico (suibokuga), disciplina nella quale è considerato uno dei più dotati pittori dell’epoca (se non addirittura il maggior rappresentante). I suoi temi preferiti erano scene naturali (soprattutto con uccelli: averle, cormorani, gufi, ecc., ma non solo) e i patriarchi e monaci Zen (Daruma, Hotei, ecc.). Tutte le su abilità, secondo la sua stessa testimonianza, sono da autodidatta, pare che egli non ebbe alcun maestro sia nell’arte della spada, sia nella pittura, ecc., sempre nel “Libro dei Cinque Anelli” egli afferma: “Ho applicato l’illuminazione sui principi di Heiho a varie arti e mestieri senza sentire la necessità di avere in tali campi alcun insegnante o maestro.”
Da sottolineare anche la sua decisione (accennata dianzi), che portò avanti all’incirca dall’età di trent’anni sino agli anni in cui fu colto dalla malattia che lo portò alla morte, di non uccidere e di non far del male a coloro i quali lo sfidavano, riuscendo, grazie alla sua grande abilità, a renderli incapaci di attaccare o contrattaccare.
Sfuggendo durante la vita agli onori, al prestigio e alla prosperità che ne poteva derivare, anche nella morte manifestò la sua sobrietà e umiltà: si arrampicò dolorosamente fino alla grotta di Reigan e, all’interno di essa, in solitudine, si pose ad aspettare, con serenità, l’arrivo della fine. Sapendo questo, uno dei suoi discepoli, recatosi da lui, riuscì a convincerlo a farsi condurre presso il castello di Chiba, dove morì il 19 maggio del 1645.